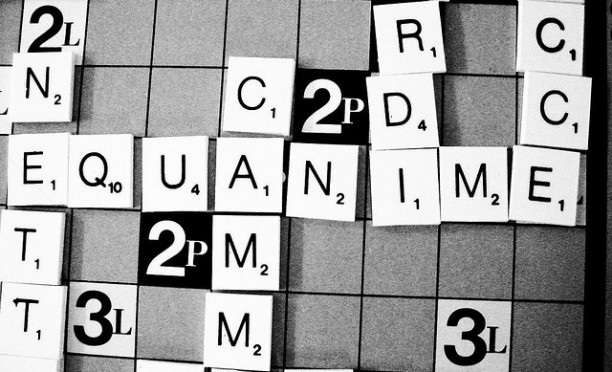Ti ricorderai delle spalle.
Io delle spalle mi ricordo. Mi hanno detto. Più dei volti e della bocca, degli occhi e di colori marcati e variegati, più della forma definita delle mani, ti ricorderai delle spalle.
Delle spalle di più.
Andare via, insieme, tutti quanti in fila, ben ordinati e silenziosi o singoli, imperfetti, con le scarpe a fare peso di sudicio dolore sull’asfalto.
E anche l’uno ti sembrerà una folla, scomposta e dirompente. Di spalle, una fiumana, un torrente, tempesta di sabbia e tu lì nel mezzo attraversato da corrente. Notando la figura e bene il passo, la movenza, lo spazio tra te e quel che manca. All’improvviso inconsistenza e non si colma, non riempi niente.
Tra le sue spalle e la tua faccia tutto il tempo perso e perso il fiato, sprecato, levigato il naso, rotto il pianto, chiuso il senso.
Tra le spalle e il petto tuo tutta la distanza, la netta differenza tra forza a spingere e fragilità a tirare, vuoto a perdere ed esigenza immatura del dare.
Tra le spalle e i piedi tuoi tutto il tragitto fatto e quello sospeso, tapis roulant, biciclette, scale a pioli, strisce bianche, bucate le scarpe, treni dimenticati dai binari, milioni di sipari, il verde l’arancione e il rosse insieme, le scie delle comete, la segnaletica imbrattata da street art 2.0.
Due i piedi, scalzi.
Ti ricorderai della spalle, sue, illuminate dai lampioni che riportano a casa. Io delle spalle mi ricordo. Mi hanno detto. Più delle mani quando non tengono e quando troppo stringono, più della giacca di panno color verde manca-la-speranza, più del timbro di voce che assopisce nella testa e del blu sul soffitto sputato nelle notti tiepide d’addii e d’attese. Più dell’incavo al centro del petto, suo, evidente a verificar mancanze primordiali e del neo sul piede mio, invisibile a sottolineare trasparenze piene, pieno il tratto a definirci. Più dei dettagli e dei sospiri, dei cortili a primavera gentili e sani.
Ti ricorderai le spalle. Io delle spalle mi ricordo. Allontanarsi piano e in riservata danza, leggere e voluttuose. Allontanarsi veloci e in concitato segno d’abbandono, forti e coraggiose.
Io delle spalle mi ricordo, mi hanno detto, mettendoci la faccia.